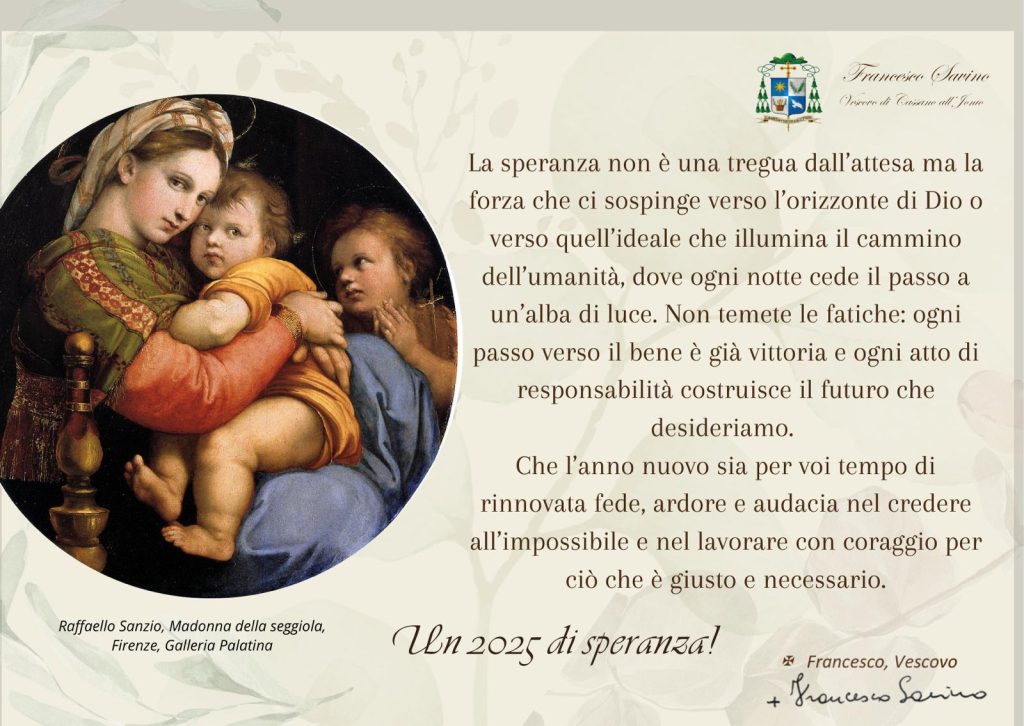S’intrecciano nella Solennità di oggi più temi: Maria Santissima Madre di Dio, l’inizio di un nuovo anno, il tempo che passa inesorabilmente, e la Giornata Mondiale per la Pace. Lasciamoci interrogare e nel contempo facciamo discernimento.
“Dopo l’annuncio dell’Angelo ai pastori (cf. Lc 2,8-14), ecco che questi ultimi, obbedienti, vanno a Betlemme e trovano Maria, la madre, Giuseppe e il bambino appena nato avvolto in fasce, deposto nella mangiatoia. Tutto corrisponde all’annuncio ascoltato, e le parole del messaggero celeste riguardo a quel bambino sono una rivelazione divina, che sarà la fede di tutti i cristiani: Salvatore, Cristo, Signore, ecco la vera identità di quel neonato (cf. Lc 2,11). I pastori non contemplano nulla di straordinario, nulla che li abbagli, ma quella realtà umanissima che vedono non contraddice le parole dell’Angelo che hanno udito; infatti, con semplicità raccontano ciò che era stato loro annunciato, destando in tutti stupore. L’evangelizzazione cristiana ha i suoi inizi quel giorno ed è fatta da poveri pastori, marginali nella loro società e ritenuti indegni di una vita religiosa espressa mediante il culto officiale” (E. Bianchi).
Maria, la Madre di Gesù “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. È la donna del discernimento! Cerca di capire ciò che sta vivendo! Mette insieme le parole dell’Annunciazione e gli eventi che ne sono seguiti: gravidanza, inizio della vita con Giuseppe, nascita di quel Figlio che veniva solo da Dio. Maria è la donna dell’accoglienza, dell’ascolto, che discerne abbondonandosi al progetto di Dio sulla sua persona. Come Chiesa dobbiamo imparare da Maria: prima di annunciare bisogna ascoltare! Rimanere sempre ascoltatori della Parola, delle persone che incontriamo e dei segni dei tempi presenti nella storia. È proprio bello iniziare un nuovo anno sociale, civile con la compagnia di Maria, la Madre di Dio, perché Lei si è svuotata di ogni pretesa del suo “io” e ha fatto spazio a Dio, alla sua Parola, generandola nella fede oltre che nel corpo. Passati otto giorni dalla nascita, Giuseppe deve adempiere la Legge, innestando il figlio maschio nell’alleanza stabilita da Dio con Abramo e significata dalla circoncisione (cf. Gen 17,1-14). Così, attraverso quell’incisione nella carne, Gesù è costituito figlio di Abramo, ebreo per sempre. La circoncisione, se da un lato rende Gesù un appartenente al popolo santo, il popolo delle alleanze, delle promesse e delle benedizioni (cf. Rm 9,4-5), dall’altro afferma la semplice ma realissima umanità di quel Figlio di Dio, Messia, Salvatore e Signore. Anche questo lo ha voluto Dio, perché l’incarnazione della sua Parola, di suo Figlio non era una finzione, non era una teofania, ma era veramente il realissimo abbassamento di Dio nella nostra condizione carnale e mortale, in un popolo preciso, che discende da Abramo, mediante la nascita da una donna (cf. Gal 4,4), come ogni figlio nasce da una madre.
Il bambino oltre alla circoncisione riceve il nome di Gesù, che significa “il Signore Salva”: è il Nome datogli dall’Angelo, da Dio stesso, Nome che dice la vocazione e la missione di questo bambino che solo Dio ci poteva donare. È bello constatare che Maria e Giuseppe obbediscono puntualmente, riconoscendo e testimoniando che quel figlio non appartiene a loro ma a Dio che lo ha voluto e lo ha fatto nascere in mezzo a noi per essere l’Emmanuele, il Dio-con-noi, il Signore e Salvatore.
Mentre contempliamo con Maria il tempo che passa e il nuovo anno che inizia non possiamo non dirci che la fine dell’anno e l’inizio di uno nuovo è un tempo sospeso, un varco tra ciò che è stato e ciò che sarà, che ci invita a sostare, a riflettere e a custodire memoria. È un’occasione per farsi custodi del tempo, raccogliendo i frammenti di un anno che scivola via, con il suo intreccio di sfide, dolori e germogli di speranza.
Eppure, non possiamo ignorare come il 2024 abbia visto crescere in modo preoccupante ciò che possiamo definire l’esaltazione della banalità.
La banalità, nel senso più profondo, non è solo una questione di superficialità o leggerezza. È un male sottile, che si insinua laddove il pensiero cede il passo all’abitudine, e il senso delle cose si smarrisce nella ripetizione meccanica. Hannah Arendt, nella sua riflessione sulla banalità del male, ci ha mostrato come il male più terribile possa scaturire non tanto da una volontà perversa, ma da un’assenza di pensiero critico, da una passività che accetta l’ordine delle cose senza interrogarsi. La banalità, in questo senso, è un anestetico dell’anima, che ci tiene intrappolati in una routine priva di profondità. «Il peggior male non è dunque il male radicale, ma è un male senza radici. E proprio perché non ha radici, questo male non conosce limiti. Solo il bene è profondo e può essere radicale; il male è quindi banale.” ( H. Arendt, Responsabilità e giudizio),
La banalità non è solo un difetto culturale: è una condizione spirituale che svuota il senso della vita, privandola di tensione e significato. Come cristiani, siamo chiamati ad andare controvento a questa deriva con il logos, la parola che illumina, che apre alla verità e al significato. Romano Guardini ci invita a riscoprire nella fede “la più alta forma di pensiero”, perché essa ci spinge a guardare oltre l’immediato e a scavare nelle profondità della vita. In un tempo che celebra la mediocrità, la nostra testimonianza deve essere un richiamo alla profondità, alla riflessione, alla speranza che abita ogni frammento della realtà. L’anno che si apre è segnato dal Giubileo della Speranza, un tempo straordinario che ci invita non solo al pellegrinaggio, ma ad un risveglio profondo dell’anima e delle scelte di vita. Al centro di questo tempo speciale, una parola si erge come chiave di lettura e di vita: responsabilità. Dietrich Bonhoeffer ci ricorda che “la responsabilità non è mai astratta, ma concreta; non è un’idea, ma un atto”. Essa ci chiede di uscire dall’indifferenza, di scegliere, di prendere posizione. La speranza è una virtù teologale, un atto di fiducia radicale in Dio e nella storia. Václav Havel, scrittore e dissidente ceco, ci offre una definizione illuminante: “La speranza non è la convinzione che qualcosa andrà bene, ma la certezza che qualcosa ha senso, indipendentemente da come andrà a finire”. La speranza non guarda solo al risultato, ma alla fedeltà al cammino, alla verità intravista e perseguita. E senza cedere al pessimismo e fatalismo, come artigiani di speranza, non soltanto vogliamo pregare e vivere oggi la Giornata Mondiale della Pace ma vogliamo essere costruttori feriali della pace giusta.
Papa Francesco nel suo messaggio per questa Giornata Mondiale per la Pace, dal titolo “Rimetti a noi i nostri debiti, concedici la tua pace”, tra l’altro sostiene: “L’evento giubilare ci invita a intraprendere diversi cambiamenti, per affrontare l’attuale condizione di ingiustizia e diseguaglianza, ricordandoci che i beni della terra sono destinati non solo ad alcuni privilegiati, ma a tutti. Può essere utile ricordare quanto scriveva S. Basilio di Cesarea: «Ma quali cose, dimmi, sono tue? Da dove le hai prese per inserirle nella tua vita? […] Non sei uscito totalmente nudo dal ventre di tua madre? Non ritornerai, di nuovo, nudo nella terra? Da dove ti proviene quello che hai adesso? Se tu dicessi che ti deriva dal caso, negheresti Dio, non riconoscendo il Creatore e non saresti riconoscente al Donatore» … Quando una persona ignora il proprio legame con il Padre, incomincia a covare il pensiero che le relazioni con gli altri possano essere governate da una logica di sfruttamento, dove il più forte pretende di avere il diritto di prevaricare sul più debole. Come le élites ai tempi di Gesù, che approfittavano delle sofferenze dei più poveri, così oggi nel villaggio globale interconnesso, il sistema internazionale, se non è alimentato da logiche di solidarietà e di interdipendenza, genera ingiustizie, esacerbate dalla corruzione, che intrappolano i Paesi poveri”.
Un augurio e un interrogativo per questo nuovo anno: un augurio di senso, un invito a riscoprire ciò che è autentico, a riconoscere nei frammenti del quotidiano i segni di un disegno più grande, a lasciare che ogni gesto si carichi di significato, perché nulla sia banale, nulla sia vano.
Che sia un anno di comunità ritrovate, di scelte che lascino il segno, di gesti concreti e radicali che diano testimonianza del Vangelo e della speranza che ci abita.
E allora vi lascio con una domanda, un interrogativo che ci accompagni nei giorni a venire: Quale traccia luminosa desideriamo incidere nel cuore del tempo che ci è dato?
Buon anno a tutti, nella speranza che illumina, nel senso che orienta e nella fede che trasforma!
✠ Francesco Savino